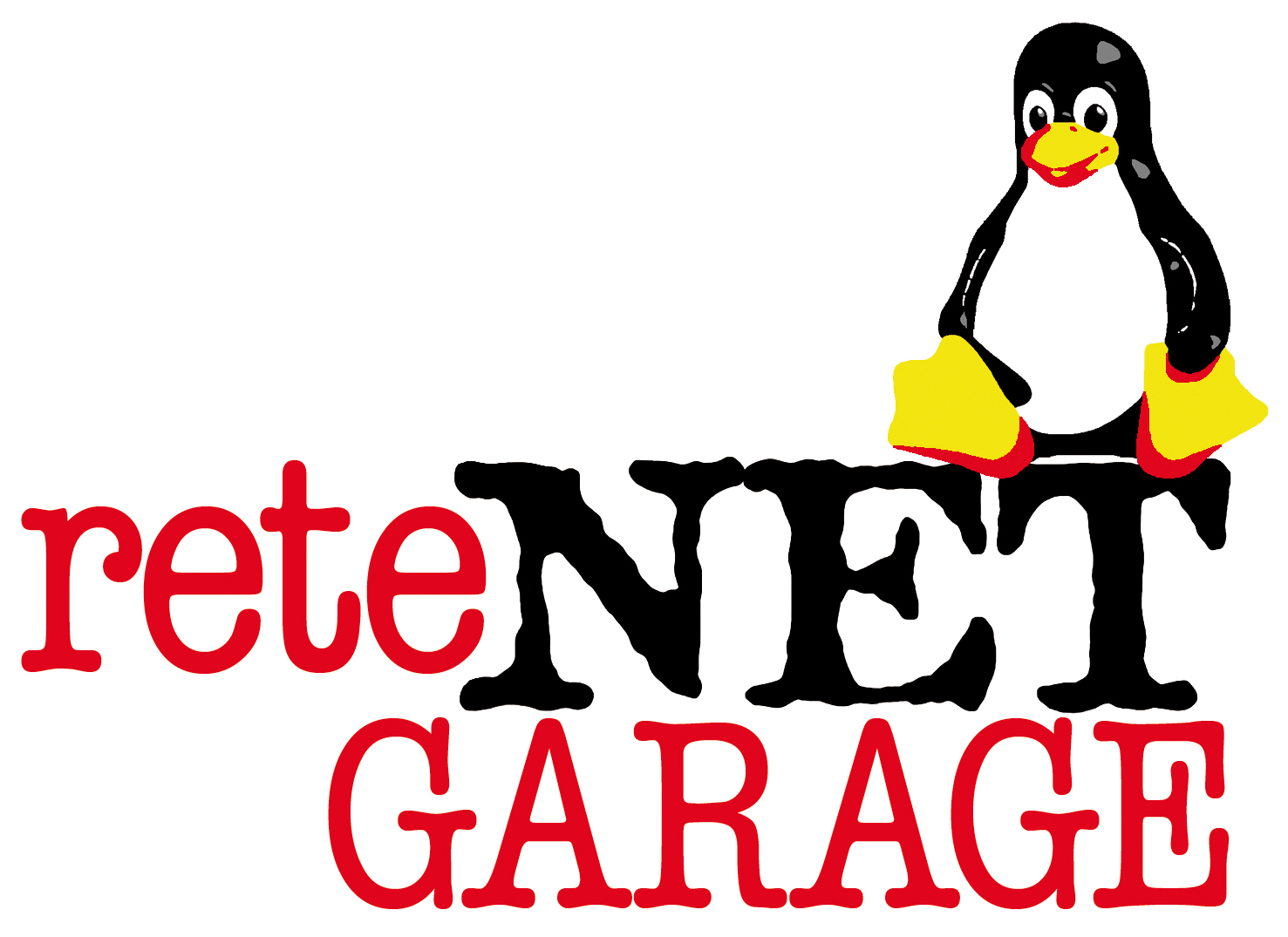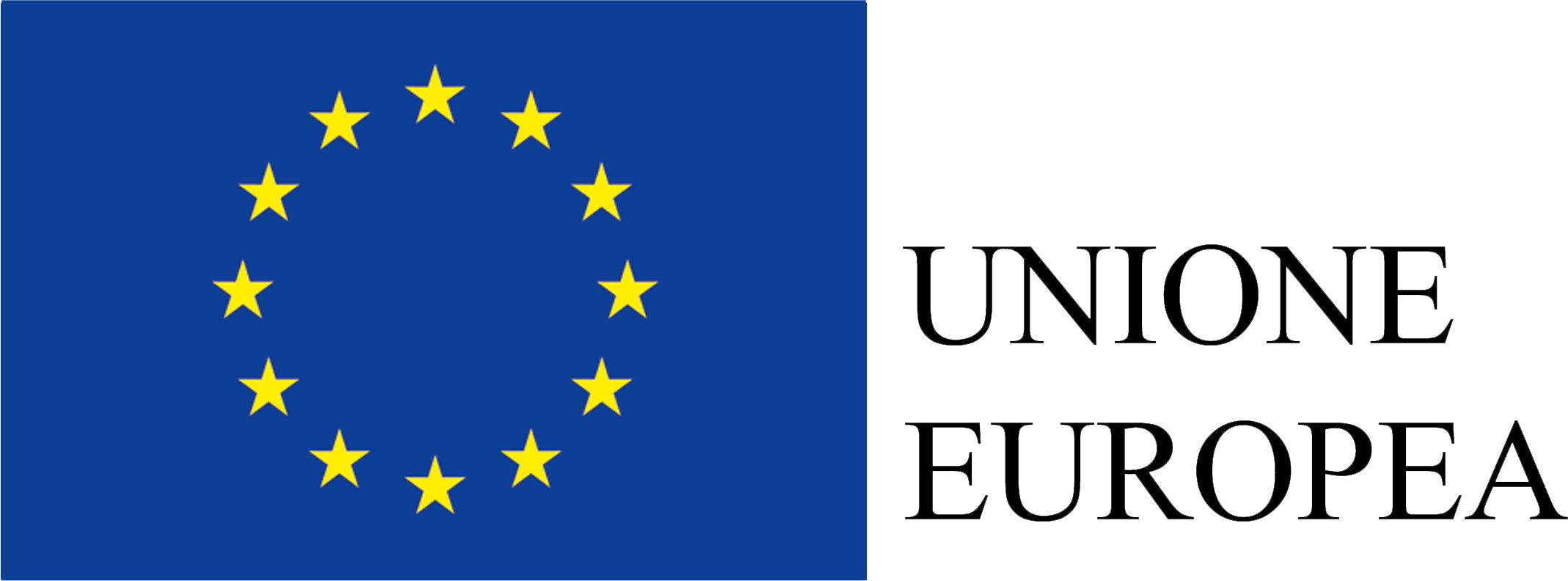BORIS ZAIDMAN (SPECIALE TORINO)
Quattro chiacchiere con l'autore di "Hemingway e la pioggia di uccelli morti"

C’è qualcosa di cosmopolitamente divertente nel dialogare con uno scrittore che ha usato l’ebraico per scrivere il romanzo di cui parleremo, rivolgendogli le domande in inglese (perché, è inutile negarlo, l’inglese è la lingua ‘internazionale’) e ascoltando le sue risposte in russo che ci vengono tradotte in italiano dall’interprete.
Russia, Israele, lingua madre e lingua dell’esilio: ascoltiamo che cosa ci dice Boris Zaidman, che è nato nel 1963 in Moldavia ed è emigrato con la famiglia in Israele quando aveva dodici anni.
E’ vero il punto di partenza del romanzo? E’ tornato in Russia dopo trent’anni?
Quando ho iniziato a scrivere il romanzo, il mio ritorno era del tutto inventato. E’ solo dopo che è diventato reale, quando sono stato invitato da un’organizzazione della mia città natale a tenere una lezione sul libro alla comunità ebraica. E’ strano, ma è così: era tutta fantasia quando ho incominciato a scrivere- è come qualcosa di mistico, la fantasia che si trasforma in realtà.
Lei sta parlando in russo, pensavo che avrebbe usato l’ebraico. Il russo resta la sua madre lingua?
Ho due lingue madri, posso spiegarmi in russo su qualunque argomento, scrivo, leggo e traduco dal russo, ma sul piano letterario preferisco utilizzare l’ebraico. In casa abbiamo sempre parlato, e parliamo tuttora, in russo. Da parte mia ho voluto coltivare la lingua e la cultura russa con un’ossessione maniacale, perché è una ricchezza che non bisogna perdere.
E che cosa ha provato quando è tornato in Russia? Che cosa ha trovato? C’è stato uno scontro tra i suoi ricordi e quello che ha trovato?
Penso ci sia sempre un momento di rottura quando confronti i ricordi con la realtà, dopo 30 anni che sei lontano. La prima impressione, la più immediata, è stata che tutto si fosse ridotto- le vie, i monumenti, tutto sembrava più piccolo. Secondo, sono tornato in un paese differente, con un altro regime. C’era stato un cambiamento radicale, la gente era vestita in maniera diversa, i contrasti tra i poveri e i ricchi erano più accentuati che ai miei tempi, quando c’era un livellamento tra le persone. Ma la cosa principale era che volevo ritrovare quel ragazzino di 30 anni prima. E l’ho incontrato, ma era un altro.
E’ stato difficile per Lei, l’arrivo in Israele? E per suo padre, di cui si avverte la nostalgia per la Russia, nel suo libro?
La nostalgia è una parte ineliminabile di ogni emigrante. Persino quelli che fuggirono dalla Germania nazista avevano nostalgia della cultura e della lingua tedesche. Noi non fummo cacciati da nessuno, quando partimmo. Mio padre non se ne renderà mai conto, ma ha una grande nostalgia di casa sua. Nel profondo l’avverte, ma è una persona molto chiusa che ormai si è abituata alla vita in Medio Oriente. E’ buffo che, quando sente parlare in ebraico, dice che stanno parlando ‘turco’, ad indicare che è incomprensibile. Quanto a me, ero un estraneo in Russia e lo ero anche qui, quando sono arrivato. A 13 anni è facile adattarsi, e tuttavia ho fatto grandi sforzi per adattarmi, tanto che è difficile che qualcuno si accorga ora, quando parlo, che non sono israeliano da parecchie generazioni. Non ho accento, non ho l’aria di ex-sovietico, e però non puoi ingannare te stesso: le mie radici rimangono là.
Questo è il suo primo romanzo e, come accade spesso, è autobiografico: è più facile iniziare parlando di sé? O è necessario iniziare da sé prima di parlare d’altro?
Qualsiasi opera prima è, in qualche misura, autobiografica. Benché tutti i riferimenti siano cambiati, questo libro non è un documento, ma una finzione letteraria. Penso che nella letteratura gli autori creino gli eroi prendendo se stessi come metro di giudizio.
Mentre cresceva, le veniva insegnato che Israele aveva usurpato i territori arabi: dopo aver vissuto in Israele per trent’anni, che cosa pensa riguardo a questo?
Penso che qualcuno che viene da fuori non possa aderire né ad una parte né all’altra; io cerco di mantenere una terza posizione obiettiva. In 30 anni ho capito che nel Medio Oriente c’è un solo dio che si chiama Forza; non so se sia bene o male, ma è un fatto. Preferisco sopravvivere, mi sembra meglio dunque essere dalla parte del più forte. Se i nostri cugini musulmani avessero la nostra stessa forza, non sarei qui a discutere. Per il momento la nostra preferenza è sopravvivere. So che a orecchie europee non suona politicamente corretto, ma non viviamo in Europa. Facendo un paragone, è come la guerra dei 100 anni tra Francia e Inghilterra. Possiamo aspettarci che tra 500 anni magari ci sia quella coesistenza che c’è ora in Europa, ma io non ci sarò per raccontarlo- anche se non bevo e non fumo.
Uno degli episodi cruciali del libro è quello del ragazzino che ritorna a casa a piedi, sentendo la bruciatura dell’insulto che gli è stato fatto: ci si abitua mai all’essere insultati con un nome che indica l’appartenenza etnica?
Nel libro si parla della quinta riga del passaporto in cui è indicata l’appartenenza etnica: a 7 anni mi sono reso conto che facevo parte della nazionalità ebraica. E’ come rendersi conto di essere nati con un handicap. E’ la stessa cosa di quanto succede in Medio Oriente, per cui è valida la lezione che mi ha dato mio padre: ‘a qualsiasi offesa relativa alla tua appartenenza rispondi solo con la forza’. D’altra parte io non potevo rispondere all’insulto gridando ‘russo’, perché quello non era certo offensivo.
La madre del bambino ha sempre paura che qualcosa possa trapelare fuori delle mura di casa. C’era ancora questa atmosfera di paura mentre lei viveva nella repubblica Sovietica?
E’ strano come quella paura di mia madre sia rimasta interiorizzata come una regola dentro di me: è meglio che non venga mai riportato fuori quello che si dice in casa. Sì, c’era questa paura e siamo cresciuti con due dimensioni: quello che si può dire in casa e quello che si può dire in strada.
 LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI
LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI