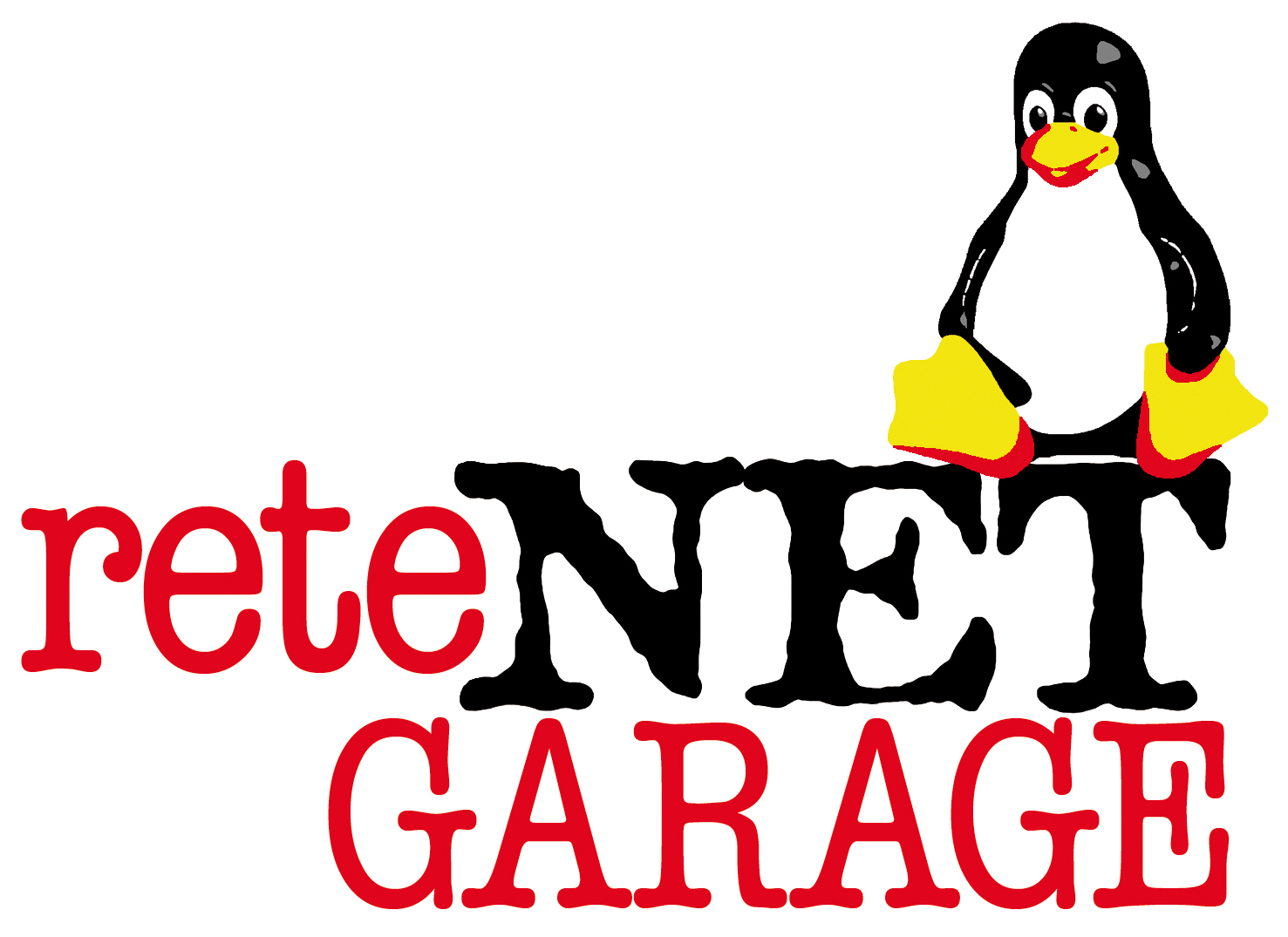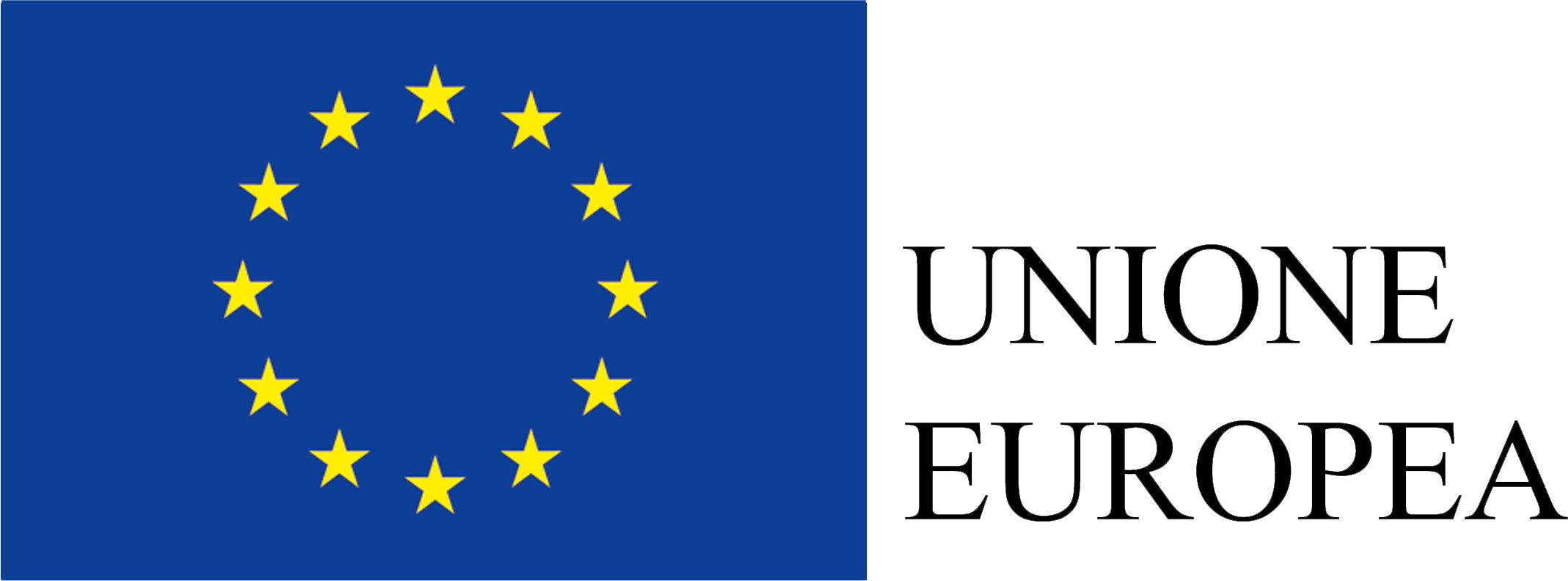AHARON APPELFELD (SPECIALE TORINO)
Intervista all'autore del romanzo "Storia di una vita"

Quando si incontra qualcuno come Aharon Appelfeld, lo scrittore nato a Czernowitz, in Bucovina, nel 1932, si prova un sentimento misto di rispetto e ammirazione. Per le difficoltà della sua vita- deportato insieme al padre in un campo di concentramento da cui riuscì a fuggire-, per il coraggio e la forza d’animo con cui si è costruito una nuova esistenza in Israele, dove è arrivato nel 1946, per la sua scrittura piana e priva di sentimentalismi che riesce ad elevare ad arte il ricordo e la sofferenza.
Abbiamo parlato con lui del suo “vecchio” nuovo romanzo durante la Fiera del Libro di Torino.
“Storia di una vita” fu scritto nel 1999, più di 50 anni dopo la fine della guerra: è come se avesse avuto bisogno di 10 anni per superare ognuno dei cinque anni di guerra?
“Storia di una vita” è il mio libro più vicino alla memoria e naturalmente dovremmo sapere che la memoria è illusoria, che in ogni momento diverso della vita ti ricordi di qualcosa in maniera diversa. E’ diverso ricordare quando hai venti anni e quando ne hai trenta. La memoria non è affidabile al 100%. Ero un bambino durante la guerra e, quando inizio a ricordare, metto in opera tutta la mia immaginazione.
Ho letto un suo altro libro non ancora pubblicato in italiano, “Tzili”, in cui Lei ci parla ancora della sua vita nel bosco, attraverso il personaggio della bambina che è la protagonista. Ne parla pure in “Storia di una vita”, ma non accenna a come sia riuscito a scappare dal campo. Se per Lei non è troppo doloroso parlarne, posso chiederle come ha fatto?
Era il ‘41, prima dell’elettrificazione del filo spinato che circondava i campi e si poteva fuggire. I tedeschi erano certi che tutti sarebbero morti di fame e di freddo. Quando hai così tanta fame e freddo, è l’istinto che ti spinge a fare cose estreme, intanto sai che non puoi perdere niente. E non so neppure se si possa parlare di coraggio, in un bambino. Il coraggio lo usi da adulto, quando sai che cosa è il pericolo. Un bambino non è consapevole del pericolo, segue il suo istinto.
Che cosa Le ha dato la forza di sopravvivere? E’ stato anche il pensiero, la speranza di rivedere i suoi genitori?
Prima di tutto per sopravvivere sai che hai bisogno di un altro pezzo di pane, di carne. E poi sì, il desiderio di rivedere i miei genitori mi teneva in vita. Io aspetto ancora di rivederli. Come ho fatto a sopravvivere, visto che ero un bambino delicato? Forse non ero così delicato, forse ero solo troppo coccolato.
Quando ci siamo incontrati in occasioni della pubblicazione di “Badenheim 1939”, mi ha detto che non poteva scrivere in tedesco, perché il tedesco era letteralmente la sua ‘lingua madre’, quella in cui le parlava la mamma. Di recente, quando il cancelliere tedesco Angela Merkel era in Israele, ci sono state delle polemiche riguardo al suo parlare- naturalmente- in tedesco, dal momento che per molti quella era la lingua degli assassini. Che cosa ha pensato, che cosa ha provato Lei?
Il tedesco è la mia madre lingua, la lingua che parlavo con i miei genitori, ma non è la lingua della mia cultura. Quella è l’ebraico: parlo bene il tedesco, ma è una lingua della quotidianità senza altre connotazioni. Io non sono una creatura politica, sento che Angela Merkel non era coinvolta nel genocidio degli ebrei. Non possiamo dire che non avremo più niente a che fare con i tedeschi di tutte le generazioni: ogni individuo dovrebbe essere giudicato dalle sue azioni.
Nel libro c’è un accenno al risarcimento che i tedeschi hanno offerto alle vittime dell’Olocausto. Questa è un’altra fonte di polemiche: si dovrebbe accettare il risarcimento oppure ci si dovrebbe rifiutare di mettere in pace la coscienza dei tedeschi?
Quando iniziò la possibilità di ricevere un’indennità, io pensai che le vittime dell’Olocausto dovevano accettare un compenso. Le persone invecchiano, si ammalano, e le vittime di quella tragedia dovrebbero essere libere dalle preoccupazioni dei soldi: hanno sofferto abbastanza. Io non la chiesi, ero un insegnante e potevo farcela, ma per altri era molto difficile. Le persone che hanno attraversato un tale inferno dovrebbero avere almeno i mezzi per curarsi la salute. Questo è quello che penso.
Prima le ho chiesto come ha trovato la forza di sopravvivere: anche scrivere è una maniera di sopravvivere?
Scrivere è un atto d’amore, è una connessione con la vita interiore, con i miei genitori e i miei nonni. Scrivere ti eleva lo spirito: è molto importante.
Questa edizione della Fiera del Libro è stata rovinata dalle discussioni sulla politica di Israele, sul fatto che la creazione dello Stato di Israele è coincisa con la Naqba dei palestinesi. Pensa che qualunque evento, anche un evento culturale come questo, abbia sempre a che fare con la politica, comunque?
La politica non è una lingua del sentimento, è una lingua di passione, e intendo passione in senso animale. Se per cultura intendiamo quello che essa è, cioè dialogo, pluralismo, capire gli altri, non ci può essere una visione unilaterale della cultura. E la politica è un’altra categoria, che non è dei nostri sensi coltivati, ma del nostro animalismo.
 LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI
LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI